Prima di approfondire
ulteriormente il pensiero di Ėjzenštejn,
vorrei soffermarmi sulla teoria del montaggio proibito proposta da
André Bazin nel manuale “Che cos'è il cinema” in
particolare nel capitolo nominato “Montaggio Proibito”.
La riflessione di Bazin
parte dalla mesa a confronto di due film per bambini. Il primo è
“Une fée pas comme les autres” di Jean Tourane e
il secondo “Le Ballon Rouge”
di Albert Lamorisse. Tramite l'analisi di queste due pellicole
vuole dimostrare come l'intervento del montaggio non sia sempre
necessario, ma anzi, rischi di compromettere la narrativa filmica.
Nel film di Tourane,
il montaggio è artificio necessario alla narrazione. L'obiettivo è
quello di antropomorfizzare gli animali inquadrati e i loro
comportamenti, al fine di renderli attori protagonisti della storia
raccontata per immagini. Secondo Bazin il montaggio è il
perno ontologico del film tanto che “l'azione apparente e il
senso che le si presta non sono praticamente mai preesistiti al film,
nemmeno sotto la forma parcellare dei frammenti di scena che
costituiscono tradizionalmente le inquadrature”. Così come con
“l'effetto Kulešov”,
è il montaggio (o il pubblico attraverso esso?) a costruire un senso
narrativo. Inoltre è importante che non accada veramente il gesto in
sé, ma sia creato solo a posteriori dalla sequenza di inquadrature.
Se i cani fossero stati ammaestrati in tal modo da saper eseguire
determinate prodezze tipiche delle azioni umane, l'attenzione si
sarebbe spostata dalla storia alla straordinarietà del gesto in sé.
.
Nel film di Lamorisse il
montaggio assume un ruolo ben diverso. Scopo del film è
zoomorfizzare un palloncino affinché segua il suo “padrone” come
un cane. La dose di finzione è la stessa, ma lo scarto per Bazin è
netto: questo film non deve nulla al montaggio. L'illusione deve
trovare conferma nella realtà oltre che nel cinema. Per il critico
“il fatto è che appunto, al montaggio, il palloncino magico
esisterebbe solo sullo schermo, mentre quello di Lamorisse ci rimanda
alla realtà.”
La specificità del
cinema si palesa non più nel montaggio, che anzi appiattirebbe la
narrazione ad un qualsiasi altro tipo di testo, ma nella validità
dell'immagine in sé. Le parole di Bazin sono molto chiare:
Eppure la
stessa storia, per quanto ben filmata, potrebbe avere sullo schermo
non più realtà del libro, e questo nell'ipotesi in cui Lamorisse
avesse preso il partito di ricorrere alle illusioni del montaggio (o
eventualmente del trasparente). Il film diventerebbe allora una
narrazione attraverso l'immagine (così come il racconto lo sarebbe
attraverso la parola) invece di essere ciò che è, cioè
l'immagine di un racconto o
anche, se si vuole, un documentario immaginario
Ci affacciamo dunque sul
tema centrale della riflessione di Bazin: l'immaginazione del cinema
ha necessariamente bisogno della sua dose di realtà. La finzione
vive nel suo rimando al reale.
Ciò che
importa è solo che si possa dire allo stesso tempo, che la materia
prima del film è autentica e che, tuttavia, << è cinema >>.
Allora lo schermo riproduce il flusso e il riflusso della nostra
immaginazione che si nutre della realtà alla quale progetta di
sostituirsi, la favola nasce dall'esperienza che essa trascende.
 |
| Crin-Blanc è un altro cortometraggio di Lamorisse preso in esame da Bazin in queste pagine. |
La situazione è
paradossale: il cinema per essere tale deve essere reale, ma allo
stesso tempo consapevole di essere finzione. Il trucco sarà pure
invisibile, ma sarà pur sempre cinema. Perché tra i tanti
“escamotage” a disposizione del cinema, solo il montaggio rischia
di invalidare il rimando a ciò che deve trascendere e mantenere allo
stesso tempo? Punto fondamentale è che per Bazin la realtà deve
essere preservata nel “semplice rispetto fotografico dell'unità
dello spazio”. In questo il critico si dimostra parecchio
radicale: “per esempio, non è consentito al regista di aggirare
col campo-controcampo la difficoltà di far vedere due aspetti
simultanei di un'azione”.
Addirittura arriva ad
enunciare una legge estetica “Quando l'essenziale di un
avvenimento dipende da una presenza simultanea di due o più fattori
dell'azione, il montaggio è proibito”.
Bazin,
però, si preoccupa subito di smussare l'intransigenza di questa
legge, proponendo la sua applicazione in base a una distinzione dei
generi e dello stile. Il montaggio è dunque utilizzabile, ma non nei
casi in cui la sua applicazione “trasformerebbe
la realtà nella sua semplice rappresentazione immaginaria
(attraverso la rottura dell'unità spaziale dell'avvenimento ndr.)”
Se non tanto nella sua
applicazione, la teoria di Bazin è sicuramente affascinante e degna
di considerazione. Sicuramente può, e deve essere ripensata,
alla luce del cinema moderno. Citando di nuovo Bazin:
Se il cinema
comico ha trionfato prima di Griffith e del montaggio è
perché la maggior parte delle gag dipendevano da una comicità dello
spazio, dalla relazione dell'uomo con gli oggetti e col mondo
esterno. Chaplin, nel Circo, è effettivamente nella
gabbia del leone ed entrambi sono chiusi insieme nella cornice dello
schermo.
Al giorno d'oggi, con la
sparizione del set e degli attori stessi (si pensi al mediocre, ma
pertinente in questo caso, “Avatar”
o all'ottimo “Gravity”)
si può ancora parlare di unità spaziale dell'avvenimento? La
corniche dello schermo può essere ancora in grado di racchiudere
dentro di sé lo spazio dell'immaginario reale?
 |
| Ripensare il Classico |


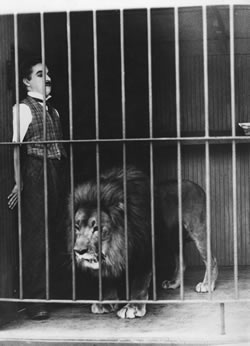
Nessun commento:
Posta un commento